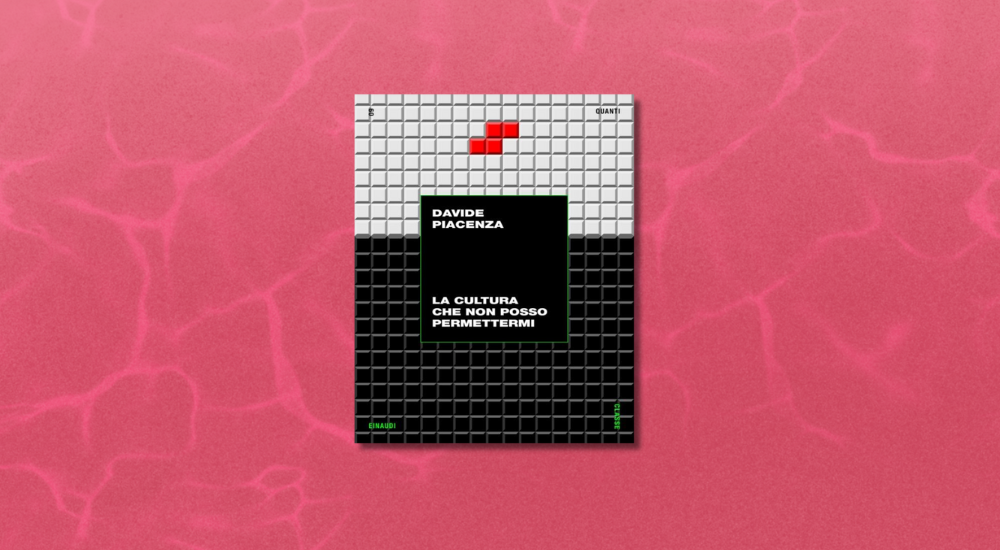Se, da giovane cresciuto in un quartiere di case popolari, ho potuto fare l’università e trasferirmi in una grande città, e poi impegnare anni in infiniti stage gratuiti e lavori intellettuali malpagati, è per tutti i viaggi che mio padre e mia madre non hanno mai fatto, per le cose che non si sono comprati e per i giorni, i mesi e gli anni che hanno passato a lavorare senza concedersi svaghi, di modo che i loro figli potessero seguire una vocazione.
Dopo essere riuscito faticosamente a superare le barriere d’accesso alla mia professione vocazionale d’elezione, il giornalismo culturale, ho però scoperto con smarrimento che il discorso dominante del mio settore d’arrivo era di segno opposto: interpretando nel modo più provinciale possibile l’approdo al cosmopolitismo, in quei circoli aspirazionali la propria provenienza familiare veniva regolarmente dissimulata, sminuita, irrisa.
Non dimenticherò mai il giorno in cui sentii uno dei miei primi colleghi definire i suoi genitori, di letture significativamente meno sofisticate e à la page delle sue, «due ignoranti» tout court. Era una nota di disprezzo che mi risultava urticante sotto un duplice aspetto: in primo luogo perché non ero abituato a quel modo altezzoso di trattare il proprio passato e la propria famiglia; ma anche perché quei due «ignoranti», coi loro lavori non intellettuali, avevano permesso al mio collega di diventare proprietario di un appartamento a Milano prima di compiere trent’anni, mentre io dividevo ancora una casetta in affitto all’estrema periferia cittadina con degli sconosciuti.
Da quella volta, non sono più riuscito a ignorare questa contraddizione che riaffiora come un fiume carsico in ogni aspetto del lavoro culturale: da una parte una rivendicazione orgogliosa dell’allontanamento dal proprio contesto sociale d’origine, appiattito in una caricatura dal carattere pedestre e obsoleto; dall’altra una totale sordità alla consapevolezza delle risorse ricevute per nascita, e senza le quali il passaggio non avrebbe mai assunto quei contorni privilegiati e aspirazionali.
[...]
Anche per questo, nonostante il complesso di superiorità paranoico-mimetica diligentemente contratto, come già succedeva a Didier Eribon, la mia vita quotidiana di transfuga di classe preda di vergogna sociale non reggeva quel discredito così metodico e pervasivo delle mie origini: «Provavo sempre imbarazzo, perfino odio, quando sentivo qualcuno parlare con disprezzo o sufficienza delle persone del popolo, del loro modo di vivere e di essere. Dopo tutto era da lì che venivo», scrive Eribon riferendosi agli anni Settanta e Ottanta, ma avrei potuto usare le stesse parole io stesso negli anni Dieci del Duemila.
Il fatto è che «da lì» ci veniva il sottoscritto, ma non la netta maggioranza dei miei colleghi: non gli altri redattori; non quattro quinti dei collaboratori e degli addetti ai lavori che gravitavano a vario titolo attorno al giornale, frequentando assiduamente i suoi eventi; e neanche gli stagisti e i neo assunti, che se resistevano più di qualche mese ed erano confermati o integrati nell’organico, tendenzialmente appartenevano a un côté economico con alte capacità di spesa.
La ricchezza, lungi dal venire approcciata con occhio critico o addirittura con sospetto, come avveniva nel contesto popolare da cui provenivo, era invece guardata con inesauribile fascinazione, estetizzata (ancora) come lifestyle del «saper vivere» e tenuta nella massima considerazione nella strutturazione dei rapporti professionali o di amicizia: una stagista che si presentava al primo giorno di lavoro vestita di capi di lusso otteneva istantaneamente più credito sociale di un redattore che non poteva permetterseli; un collaboratore che disponeva di risorse economiche tali da non aspettarsi pagamenti puntuali valeva più di un povero diavolo magari di talento, ma che necessitava di saldi regolari delle sue fatture.
E così nel parterre della conoscenza sedevano figli della borghesia imprenditoriale di provincia, di medici cittadini, di avvocati dell’hinterland, di dentisti, di finanzieri, di dirigenti d’azienda, di famiglie con a disposizione diversi appartamenti milanesi da affittare, i cui proventi andavano a foraggiare la produzione di longform lungimiranti sulla rinnovata centralità della narrativa cinese, o recensioni che sciorinavano nomi di autori nordamericani mai veramente approfonditi.
E tutto intorno alla mia piccola redazione, iniziavo a scoprire, il fortino intellettuale era presidiato in modo anche più stretto. Nei colophon, nelle copertine, nelle e-mail e nei ringraziamenti ricorrevano cognomi noti o notissimi, dato che il grado zero della cooptazione inter pares, nel mondo della cultura italiano, è agevolare la carriera del figlio o della figlia: una pratica comunissima, quasi standard, che raramente diventa oggetto di controversia pubblica (e, le rare volte che accade, il sistema fa quadrato per difendere il rampollo sotto attacco, facendo passare le critiche al figlio per uno strumento con cui screditare il padre o la madre e chiamando in causa l’ineffabile idolo dell’«invidia sociale»). Succede anzi, e non raramente, che il cooptato o la cooptata di fortunati natali rivendichino il loro ruolo di «figli di» con progetti artistici, programmi televisivi, libri e podcast realizzati in dialogo coi genitori-gatekeeper, i quali poi magari tornano a firmare editoriali che lamentano l’assenza di meritocrazia in Italia.
Quel che era peggio, nel piccolo feudo culturale in cui mi ero conquistato il grado di valvassino nessuno – non è un’iperbole, anzi va inteso in senso letterale – era figlio di un piccolo impiegato e di una casalinga, come il sottoscritto. E come tanti figli unici, talvolta mi sentivo un po’ solo: puoi provare a fingere appartenenza quanto vuoi, ma il capitale culturale con cui sei cresciuto non ti abbandonerà tanto presto, e con esso il senso di inadeguatezza e di non aver letto abbastanza, di non aver visto abbastanza, di non aver studiato abbastanza, nonostante anni di recupero febbrile ed entusiasta, costruiti sui sacrifici di due «ignoranti» trasferitisi in città con l’urbanizzazione degli anni Settanta.
Ma soprattutto, a non abbandonarti sarà l’evidenza delle cose materiali che puoi permetterti, che non risulterà mai, in nessun caso, equiparabile a ciò che può permettersi un figlio della borghesia benestante. Non conto le volte in cui il mio abbigliamento – i miei jeans ancora da fiera di paese, le mie scarpe cosí orrendamente low cost – è stato seguito da sguardi irrisori e beffardi [...]. Con meno frequenza, ma non troppo di rado, capitava che qualcuno si lasciasse andare a commenti ad alta voce, magari osservando le mie sneakers da pochi euro: «Non le cambiamo queste, eh Piacenza?».
Al tempo non l’avrei definito in questi termini – ero, ai miei occhi come con ogni probabilità a quelli altrui, solo un ragazzo di provincia un po’ uncool che doveva ancora introiettare i codici della vita raffinata di città – ma quella forma di classismo strisciante e onnipervasivo condizionava la mia percezione identitaria in modi e maniere che non facevano che alimentare la mia dissociazione sociale: ora leggevo i libri «giusti» e ne scrivevo sulle testate «giuste», parlando in pausa pranzo delle serie tv «giuste» e delle cose «giuste», ma usando i criteri di giudizio degli altri ero ancora un figlio delle case popolari, della «via degli albanesi», un intruso in luoghi di consumi illuminati e outfit all’ultima moda; un usurpatore di spazi non adatti a quelli come me, insomma.

- Bruno Montesano sulla «morte del politicamente corretto», su MicroMega;

- Il Post parla della «“guerra culturale”», tra virgolette, ai soffiatori di foglie;

- Analisi pazzesca che ti spiega perché Papa Leone XIV non è basato.