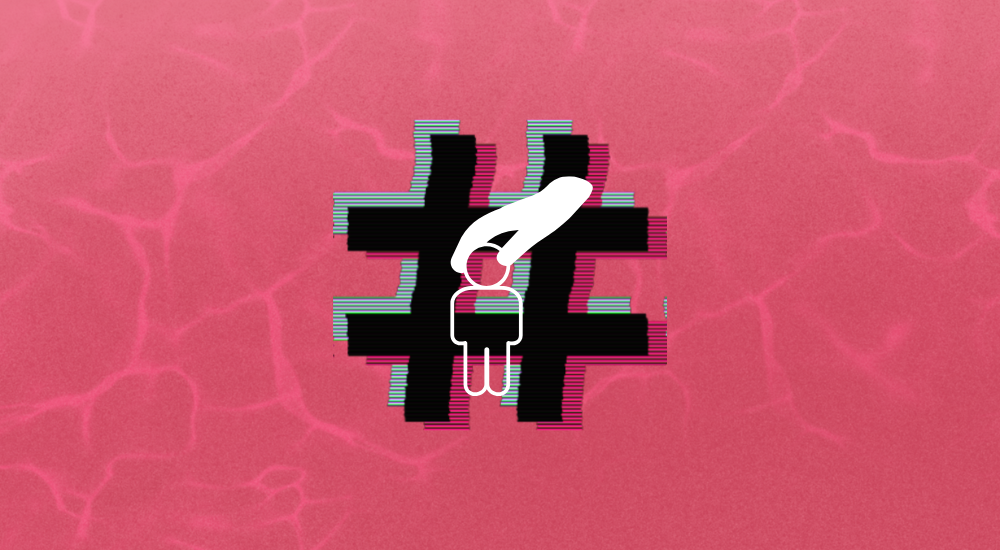C’è stato un momento, a febbraio del 2022, in cui ogni settimana quasi 10mila video su TikTok hanno raggiunto la soglia dei 10 milioni di visualizzazioni. Tradotto: in un mese circa 40mila contenuti di account di ogni genere sono stati visti almeno 10 milioni di volte ciascuno. Creando tendenze, fenomeni virali, nuovi personaggi e uno star system a misura di algoritmo.
Del resto, Alex Zhu – fondatore di Musicall.ly, che poi sarebbe diventato TikTok – lo aveva detto in un’intervista del 2016: ai social network serve, più di tutto, una nuova America. Uno spazio in cui chiunque, in qualunque momento, possa trovare la notorietà.
È una delle chiavi del successo della piattaforma cinese in un mercato difficile e dominato dai soliti noti: la sensazione concreta, offerta agli utenti, di avere davvero la possibilità di costruire qualcosa di nuovo, in una pianura brulla che potrebbe ricordare l’Ovest degli Stati Uniti. È la fabbrica da un milione di follower, come in una fortunata definizione coniata dal sito The Information.
TikTok ha consolidato l’idea che chiunque possa diventare un influencer: magari sei solo un ragazzo che fa facce buffe, o fai panini, o metti cover al cellulare. Non conta. Basta ci siano i contenuti, perché il resto lo fa l’algoritmo.
Guardare la sezione «Per te» di TikTok dietro questa lente di ingrandimento fa un effetto particolare. Lo ha notato anche il New York Times, che in un bell’articolo ha raccontato come questa illusione condiziona il comportamento della Gen Z sulla piattaforma. Non è solo la costante creazione di contenuti, l’idea di dover avere un piano editoriale, il seguire format ormai codificati come il «Prepariamoci insieme». È anche la volontà di convertire l’attenzione – anche quando, in fin dei conti, non è poi così tanta – con l’offerta di buoni sconto e liste dei desideri su Amazon.
Insomma, è il linguaggio dell’influencing che diventa senso comune, favorito da una caratteristica della piattaforma. Un ambiente che offre a tutti la possibilità – anche se del tutto ipotetica e imprevedibile – di raggiungere un determinato ruolo sociale o professionale.
In una guida del MIT che si intitola, in modo lapidario, Content, Kate Eichhorn mette in fila un paio di concetti importanti per capire questo fenomeno. Il primo è una definizione del contenuto, tra i veri iperoggetti del XXI secolo, che:
Può contenere un’informazione di vario genere, raccontare una storia, intrattenere, ma non deve fare nessuna di queste cose per circolare in maniera efficace.
Perché il punto finale è proprio questo: che si diffonda, che giri, che sia potenzialmente disponibile a un numero enorme di persone.
Accanto a questa definizione, Eichhorn fa un passo avanti importante e parla del concetto di Content capital, il capitale di contenuto. Si tratta di un’idea molto simile a quella di capitale culturale, introdotta da Pierre Bourdieu, secondo cui beni intangibili come l’istruzione, il modo di vestirsi o di comportarsi influenzano la posizione sociale di una persona e le sue opportunità di mobilità sociale.
È esattamente quello che fa il capitale di contenuto, che è però formato dalla somma dei contenuti prodotti e pubblicati online. Non è il frutto di una condizione sociale di partenza, né tantomeno del possesso di oggetti culturali: è una funzione diretta dell’attività online. In altre parole, sono credibile su un determinato argomento – e posso quindi sperare di emergere in quel settore – se ho a disposizione un numero importante di contenuti su quel tema. Se sono algoritmicamente presente, se esisto nello spazio in cui la quasi totalità delle persone del mondo passa una parte consistente del suo tempo di veglia.
Del resto, in un libro del 1980, Divertirsi da morire, Neil Postman parla della verità come di una conversazione tra l’essere umano e i mezzi di comunicazione. E dice una cosa apparentemente semplice: ci fidiamo di più dei contenuti espressi in format con cui abbiamo familiarità, su mezzi che frequentiamo su base quotidiana. E quindi di Kennedy, più che di Nixon; o di Berlusconi, più che di Occhetto; oppure, venendo a oggi, di un anonimo salumiere napoletano che fa video su TikTok, piuttosto che del consiglio di un amico.
È una visione del mondo che porta con sé una serie di conseguenze. Se dire la propria non è più solo un modo di relazionarsi alla propria rete sociale, ma anche un metodo per guadagnare una posizione, tutto diventa contenuto. Ogni momento diventa un’opportunità di testimonianza, uno spunto per consolidare il proprio capitale. Ed è un concetto che si può applicare a qualunque campo, dalla produzione culturale al giornalismo, fino al turismo, che si trasformano in nient’altro che una serie di content opportunity.
Il punto è che se tutto è contenuto, cambia anche il modo che abbiamo di reagire a quello che vediamo. Ne parla bene ne Il contagio Walter Siti, in un discorso riferito alla società dello spettacolo, mediata e resa possibile da un certo tipo di televisione.
Se percepiamo il mondo come un prodotto artistico allora valgono per il mondo le regole che valgono per le opere d'arte, cioè l'indifferenza morale e la sospensione dell'incredulità. Tra una realtà concreta ma deprimente e una rappresentazione seducente ma immaginaria, scegliamo la seconda.
Portiamo questo concetto a una società dello spettacolo onnipresente, in cui non esiste il filtro all’ingresso delle reti televisive o dei produttori cinematografici. E in cui la produzione di contenuti diventa un modo per costruire sé stessi non solo in relazione agli altri, ma anche rispetto alle proprie specificità culturali e professionali. Il mondo si tramuta in una raccolta di opportunità da cogliere per fare un contenuto. L’influencing, la grammatica dietro la produzione di contenuti, diventa ideologia, per dirla con Slavoj Žižek: ovvero una sovrastruttura che rende il mondo un format, e che ci impedisce di vederlo per come è davvero.
Tempo fa, il giornalista americano Ezra Klein scriveva che Twitter è «una gamification del dibattito pubblico». I social media sono questo, più di ogni altra cosa: un gioco del mondo, per dirlo con Cortazar. Il punto è capire cosa succede quando le regole del gioco diventano le regole del mondo.
Altre news dal fronte
- Target, la catena di negozi più popolare d’America, ha annunciato di aver tolto dagli scaffali alcuni oggetti in vendita legati al mese del Pride dopo che dei suoi dipendenti sono stati oggetto di attacchi politicamente motivati negli store;

- Infine Ron DeSantis, il machiavellico governatore della Florida, si è candidato alla presidenza degli Stati Uniti: e già nel video di lancio della campagna si ravvisano le sue fissazioni sul versante culture wars;

- «Ce l’abbiamo fatta!», giubilarono quelli, celebrando un coro virale di insulti, violenza verbale e minacce che ha portato un tizio che non la pensa come loro a lasciare una piattaforma.

(aggiungi l’indirizzo ai tuoi contatti, altrimenti rischi che la newsletter finisca nella cartella Spam)