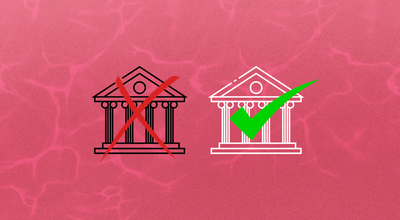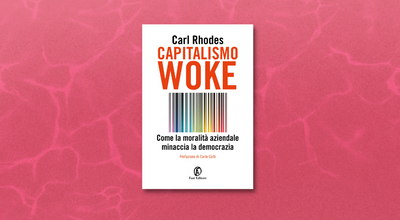Faccio la bioeticista di professione. Ho sempre lavorato in università all’estero, negli Stati Uniti prima e poi nel Regno Unito. Il mio ex dipartimento al King's College di Londra, Global Health and Social Medicine, è stato uno dei primi promotori del movimento detto di “decolonizzazione del piano di studi” (cioè articolato attorno allo slogan decolonize the curriculum): un approccio volto a aumentare la diversità di autori provenienti dai low and middle income countries (o LMIC), e dai Paesi ex coloniali, nei sillabi dei corsi dell’università.
Quando sono arrivata, nel 2013, non si parlava ancora di decolonizzazione. Il dipartimento era stato messo in piedi pochi mesi prima, in seguito alla migrazione di un gruppo di persone che sotto la guida del sociologo Nikolas Rose lavoravano all’adiacente London School of Economics su biopolitica, tecnologie e società. Il King’s College offrì loro la possibilità di imbastire un dipartimento in scienze sociali, salute e medicina (si chiamava così, inizialmente: Social Sciences, Health and Medicine), un dipartimento interdisciplinare fatto di persone con formazioni diverse interessate alle ramificazioni sociali, culturali, politiche ed etiche delle nuove tecnologie della vita, nel solco di Michel Foucault e di Paul Rabinow.
Nel 2016, le cose hanno cominciato a cambiare, e in fretta. Prima c’è stato il cambio di nome del dipartimento. L’idea che stava prendendo piede era che la bioetica fosse meno di richiamo rispetto alla “Global Health and Social Justice”, che era diventato il master bandiera del dipartimento e attirava più studenti, soprattutto da oltreoceano (i quali pagano il doppio di tasse universitarie). Quindi il dipartimento è stato ribattezzato Global Health and Social Medicine. Altri dipartimenti oltreoceano avevano fatto mosse simili già qualche anno prima, come quello di Public Health a Harvard, rinominato Global Health.
Poi sono arrivate le politiche attuate dall’alto verso il basso in ateneo, sempre col fine dichiarato di decolonize the curriculum. Durante la pandemia sono state emesse linee guida basate su un’analisi quantitativa del numero di autori di Paesi low and middle income contenuti nei sillabi del nostro dipartimento, volte a incoraggiare – prima – e a obbligare – poi – i coordinatori dei corsi a cambiare i propri programmi per renderli più inclusivi di comunità marginalizzate, e a rispettare metriche quantitative di rappresentanza.
L’obiettivo lodevole non è però epistemicamente neutrale riguardo all’oggetto di studio della materia. Gli autori stranieri di università degli LMIC, per cominciare, si occupano mediamente meno di bioetica, e per questioni di forza maggiore: i loro stati di provenienza hanno problemi più urgenti della modificazione del genoma umano attraverso tecnologie Crispr o delle cellule staminali indotte pluripotenti, dovendosi spesso occupare di epidemie di malaria, tubercolosi o Zika.
Quando l’ho fatto notare all’amministrazione, mi è stato detto che erano gli studenti a voler essere esposti a più temi di giustizia globale e sociale. Eppure, per mia esperienza, se uno studente universitario sceglie di studiare bioetica è perché è interessato allo studio dell’impatto delle nuove tecnologie sulla società. Altrimenti sceglie qualcos’altro. Se si sostituiscono i temi della bioetica con altri discorsi, magari politicamente impegnati, si insegna una materia diversa: cosa che ci sta, e che va anche bene, ma va dichiarata. Così magari anche chi si iscrive fa scelte informate e non si trova ad aver scelto (e a stare pagando quasi 12mila sterline all’anno) un master in bioetica dove più di metà del piano di studi in realtà copre temi di giustizia sociale e salute globale.
In una occasione mi è capitato di non cogliere una sfumatura della lingua inglese usata da un’interlocutrice in una mail. La persona in questione aveva scritto «we are expecting», e io le avevo risposto facendole congratulazioni per la sua gravidanza. Una collega, che ricopriva una posizione più senior della mia e che ci leggeva in copia, mi ha risposto separatamente con una lunga e altezzosa email, dicendo di sentirsi «mortificata» dalle mie parole e dal mio aver imposto i miei presupposti normativi eterosessuali su altri.
Ho chiesto di potermi chiarire (lei aveva scritto «we are expecting», non «I am pregnant»: la prima è una locuzione che in inglese possono usare partner di persone in gravidanza – sia donne che uomini – per riferirsi alla coppia). Mi sono scusata di aver involontariamente offeso. La mia collega senior mi ha spiegato che la regola è presupporre che la persona che si ha di fronte appartenga a una certa sottocategoria di sottocategoria di minoranza: così facendo, non si offenderà nessuno. La destinataria della comunicazione, la cui partner era in stato di gravidanza, non ci aveva nemmeno fatto caso. Eppure la mia collega in una posizione senior nel dipartimento mi aveva accusato a prescindere, insinuando la mia inadeguatezza a insegnare per via delle mie supposizioni eteronormative. C’erano dinamiche di potere in gioco, e nei suoi toni nessuna attenuante. Perché questa ostinazione a creare il conflitto tra supposte identità imposte alle persone dall’esterno anche in casi, come questo, in cui non ce n’è bisogno?
L’ultimo episodio significativo in cui sono stata coinvolta in maniera diretta è il processo di selezione di un nuovo candidato per una posizione come lecturer in dipartimento. La selezione di ogni nuovo membro dello staff accademico nel Regno Unito avviene in due step: un primo che prevede lo screening dei candidati e la decisione di chi ammettere alla prova orale, e il secondo in cui viene valutata la prova orale. Non è detto che chi fa parte della commissione che giudica quali candidati ammettere alla prova orale faccia poi parte dei membri della commissione che presiede la prova orale; anzi, la seconda solitamente è composta da persone senior del dipartimento o facoltà che non si sono prese la briga di esaminare tutti i candidati.
In questo episodio io facevo parte della prima commissione, ma non della seconda. La discussione con gli altri colleghi di dipartimento coinvolti nella selezione su chi invitare al colloquio è subito virata verso quali candidati appartenessero a una minoranza etnica marginalizzata. Solo questi candidati sarebbero stati considerati ammissibili alla prova orale, in quanto in linea con il progetto di aumentare la «diversità e inclusione» del dipartimento.
Dopo aver fatto notare che non mi sembrava giusto mettere in atto regole che non erano specificate da nessuna parte nell’annuncio di lavoro, e in base alle quali per inciso io stessa non avrei mai ottenuto il mio posto di lavoro in università, i membri senior della commissione mi hanno risposto che non si trattava di una questione personale: bisognava aumentare la diversità dello staff accademico, rispondendo alle esigenze del corpo studentesco. Un candidato non si può valutare coi criteri oggettivi delle scale di valutazione e del “merito”, mi è stato fatto notare, perché far parte di una minoranza obbliga sempre e comunque a partire svantaggiati. Essere emigrati dall’Italia all’estero, magari da primi nella propria famiglia ad aver conseguito un titolo di laurea, invece non conta.
Le questioni sono molto complesse e meritano di essere affrontate con ogni cautela e sensibilità, ma un’affirmative action messa in atto in questo modo attualizza la minaccia dello stereotipo, un fenomeno noto in psicologia che definisce l’internalizzare messaggi come “non sono bravo abbastanza”, “non sono abbastanza competitivo” (delusioni specialmente efficaci su donne, come dimostrano molti dati in questo campo): alcune persone che non vengono ammesse al colloquio giungeranno alla logica conclusione di non esserselo meritato, e smetteranno di fare domanda alla prossima opportunità.
Non tutti, inoltre, sono d’accordo sul fatto che la decolonizzazione attraverso la riscrittura dei curricula e l’assunzione guidata di persone di pelle non bianca sia il mezzo giusto per aumentare la diversità in università. Qualche voce critica comincia a farsi sentire: Olúfẹ́mi Táíwò, professore associato nigeriano-americano di filosofia alla Georgetown University, autore di Against Decolonisation, sostiene che queste strategie in realtà sono volte a infantilizzare autori che provengono dall’Africa o altri Paesi LMIC, e a imporre su di loro visioni di cosa dovrebbero studiare e cosa dovrebbero insegnare, separandolo nettamente da ciò su cui i colleghi bianchi possono (o devono) scegliere di specializzarsi.
La mia decisione di licenziarmi a settembre di anno scorso è dipesa da una concomitanza di fattori: pandemia, Brexit e questioni di logistica familiare, ma è vero anche che mi sono sentita tagliata fuori in modo crescente dal fare bioetica in un dipartimento votato all’anti-racism e alla Social Justice, dove decolonising the curriculum voleva dire, se possibile, per questioni di coerenza, mettere ai margini o rimuovere dallo staff anche persone come me, per sostituirle con altri tipi di “corpi”.
Anche il master in bioetica e società al King’s non esiste più. Non c’è da sorprendersi, forse: portava pochi introiti, e nella missione di decolonizzazione dell’offerta formativa del dipartimento la bioetica non serviva più. Tuttavia, gli studenti, almeno quelli che ho incontrato io, non guardano al colore della pelle o al tipo di corpo che un insegnante ha; anzi, vedono cosa c’è sotto: un po’ di conoscenza appresa attraverso sudate carte, e poi passione per la materia, desiderio di scambiare conoscenza con altre persone, diverse ma non in quanto etichettate come tali, e di contribuire assieme attraverso un processo critico alla creazione di nuova conoscenza. E questo è il motivo per cui, amarezza verso l’istituzione a parte, resto ottimista per il futuro.
Altre news dal fronte
- Il grande segreto della viralità su Twitter;

- Suprematismo bianco letteralmente ovunque;

- Due terzi d’America è contraria all’ondata di leggi repubblicane sulle persone transgender.

(aggiungi l’indirizzo ai tuoi contatti, altrimenti rischi che la newsletter finisca nella cartella Spam)