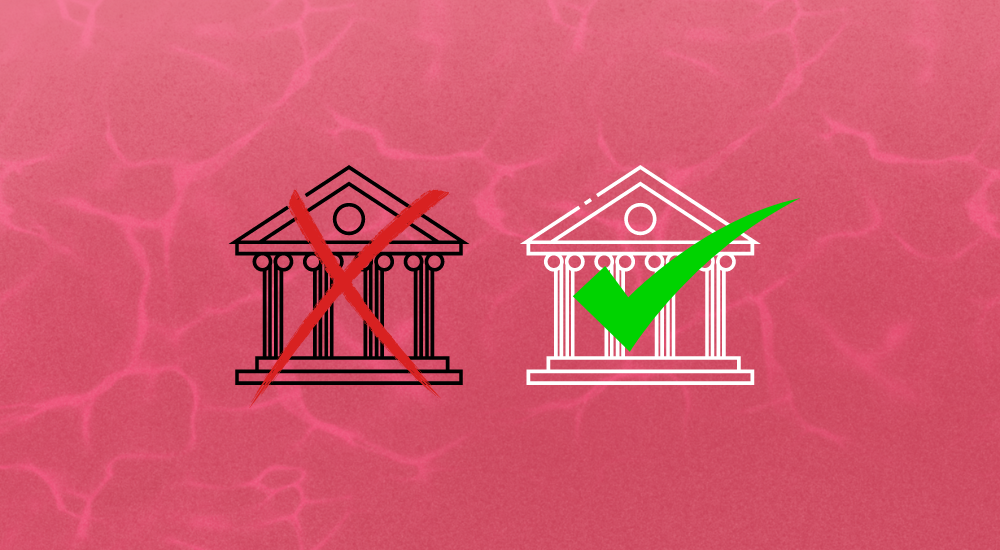Inizio da un disclaimer che ti devo, lettore o lettrice, dato che ognuno di noi ha le sue prospettive ed è bene dichiararle: su Israele e Palestina penso che in questa fase ci sia uno Stato che sta commettendo crimini ai danni dei civili e un popolo che li sta largamente subendo, e in modo sproporzionato. (Ci sarebbero migliaia di post-scriptum e addendum da allegare a questa affermazione semplicistica, ma concedimi l’occamismo e procediamo).
Lo dico da una parte perché sulla questione non mi sto esprimendo, almeno sui social – troppa distorsione, troppo posizionamento sotto steroidi, troppo rumore bianco: le solite cose – e dall’altra perché la precisazione possa affiancare e completare il discorso che segue, che è il punto di questa edizione.
Martedì la Commissione sull’Istruzione e i lavoratori della Camera statunitense ha audito le presidi di Harvard, MIT e University of Pennsylvania sugli sforzi dei loro atenei per contrastare i discussi casi di antisemitismo finiti nelle cronache delle ultime settimane (anche se una lista o mappa aggiornata, che io sappia, non esiste, si tratta soprattutto di atti di vandalismo anti-israeliano e uso di slogan considerati antisemiti a manifestazioni pro-Palestina; qui, invece, qualche dato in merito alle mutate percezioni di sicurezza degli studenti ebrei nei campus statunitensi).
A rubare la scena in aula sono state le domande particolarmente pugnaci poste dalla repubblicana della Commissione Elise Stefanik a Claudine Gay, che è preside di Harvard da poco più di cinque mesi. Stefanik ha chiesto ripetutamente a Gay se «dirsi favorevoli al genocidio degli ebrei» viola o meno «i codici di condotta di Harvard», chiedendo una risposta breve e affermativa che la preside – come le sue colleghe – non ha voluto dare.
Harvard è particolarmente sulla graticola fin dai fatti del 7 ottobre, quando un gruppo di suoi studenti filopalestinesi aveva diffuso una lettera che attribuiva a Israele la responsabilità politica e morale dell’eccidio di Hamas, e per questo motivo era stata molto criticata. Quando Stefanik parla di sostenitori del «genocidio», però, si riferisce alle manifestazioni studentesche in cui si cantano slogan per l’Intifada e altri motti come «from the river to the sea, Palestine will be free», considerato da alcuni intrinsecamente antisemita.
Prima di procedere: se anche i canti degli studenti di Harvard fossero di contenuto antisemita, ritengo che ci voglia molta motivazione per considerarli sfrontati richiami genocidari. E per quanto i casi di molestie ai danni degli ebrei nei campus siano un tema che richiede una pubblica discussione, è triste che questa discussione nelle istituzioni sia stata affidata alla deputata Stefanik, la cui buona fede – come nel caso di tanti altri suoi compagni di partito – è testimoniata dal fatto che non più tardi dell’anno scorso diffondeva teorie complottiste sugli ebrei cattivi che controllano il mondo. Per dire.
C’è tuttavia una formula ricorrente, nelle risposte date dalle presidi delle prestigiose università dell’Ivy League alla Commissione: «Dipende dal contesto». Nel difendersi dalle lance in resta dei deputati, sia Gay che le sue omologhe hanno dichiarato a più riprese che, anche nei casi di antisemitismo, bisogna differenziare tra parole e atti.
«Quando le parole si trasformano in comportamenti che violano le nostre politiche, comprese le politiche contro il bullismo, le molestie o le intimidazioni, prendiamo provvedimenti», ha detto la stessa preside di Harvard. E ancora:
[A Harvard] Abbracciamo e ci impegniamo per la libera espressione, diamo ampio spazio al free speech, anche quando riguarda punti di vista discutibili.
Eppure non è proprio così (e, purtroppo, nell’averlo fatto notare stavolta ha avuto ragione Stefanik): da una decina d’anni le università americane d’élite, organismi con board finanziari da cui passano finanziamenti milionari, hanno preso la strada che va in direzione nettamente opposta rispetto all’impegno per la libera espressione che considera il contesto e lo scarto tra parola e azione. L’opinione confliggente o la privata condotta extra-accademica sono diventate forme accertate di harm, male inferto, e una singola segnalazione di uno studente che non si sente più safe attiva burocrazie gargantuesche, talvolta con effetti paradossali.
Ha scritto in queste ore l’autore e psicologo Jonathan Haidt:
Ciò che mi offende è che dal 2015 le università si sono affrettate a punire le “microaggressioni”, un contenitore in cui sono finite dichiarazioni intese con gentilezza, se anche una persona di un gruppo tenuto in considerazione si fosse sentita offesa. I presidi invece ora dicono: “Gli ebrei non sono un gruppo considerato, quindi offendere o minacciare gli ebrei non è poi un grosso problema. Per gli ebrei, tutto dipende dal contesto”. Potremmo chiamare questo doppio standard “antisemitismo istituzionale”.
Ora: io non penso che esista un «antisemitismo istituzionale» a Harvard o al MIT di Boston; o, se esiste, non penso che la pistola fumante in tal senso possano essere un responso sgangherato a una lettera studentesca o le mezze risposte di una preside in sella da meno di metà anno. Sarà perché mi sento vicino alla causa palestinese? Può darsi.
Quel che conta però, ai fini del mio punto, è che quel «doppio standard» di cui parla Haidt esiste davvero: non si può sostenere per anni, e con veemenza variabile, che la vera violenza è nascosta nell’uso di pronomi sbagliati ed espressioni quotidiane da decostruire e poi un bel giorno, con nonchalance, passare ad assicurare che lo slogan sul fiume e il mare va valutato solo sul piano del contesto e delle buone intenzioni di chi lo usa.
Non si può fare campagna sull’harm insito nell’invito a parlare in un’aula universitaria di uno scienziato che ha criticato le politiche di diversità e inclusione, da una parte, e dall’altra pretendere che nessuno alzi un dito se nella tua facoltà si spiega che una strage come quella di Hamas è una normale pratica di decolonizzazione.
Per chi avesse ancora dei dubbi, chi scrive è ampiamente nel campo di quelli che privilegerebbero sempre il contesto, le intenzioni, la carità interpretativa, a prescindere dalla materia del contendere. E, nel caso, se qualcuno ha cambiato idea e attraversato le barricate, lo accolgo a braccia aperte e, francamente, provo sollievo.
I college e le università americane oggi sono però ancora lontani da questa presa di coscienza: chi ha provato a fargli aprire gli occhi – come i nuovi movimenti per il dialogo civile – e riportare studenti e professori in una realtà dove lo scambio di opinioni divergenti non porta necessariamente alla rigida polarizzazione burocratizzata e alla reciproca censura, per ora ha detto di non aver ricevuto l’attenzione che i board e gli ingranaggi di Harvard rivolgono a gruppi più à la page. Ma i tempi cambiano: con calma, a volte, ma cambiano. Ed a prescindere dal contesto.
Altre news dal fronte
- Uh-oh, una Babba Natale femmina e afrodiscendente ha rovinato le festività a quei bambinoni della destra belga;

- Donald Trump, probabile prossimo presidente degli Stati Uniti, ha una nuova missione importantissima: salvare le ciambelle;

- Il buon Hegel nell’era della cosiddetta wokeness.