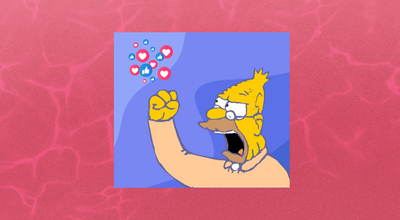Buongiorno (o buonasera: non discrimino nessun fuso orario), sono Davide Piacenza e questa è Culture Wars, la mia newsletter su quelle macchine infernali chiamate social network, e su come stanno facendo a brandelli la nuova – e complicatissima – comunicazione globale di quest’epoca.
Ci tengo a salutare di nuovo Lena, aka @bravebirdie, l’illustratrice ucraina che ha realizzato il disegno che illustra la newsletter. Spero di saperla presto al sicuro.
La trincea dell’algoritmo
Sì, ce l’abbiamo fatta: abbiamo trasformato una guerra con migliaia di morti, milioni di sfollati, tantissime esistenze spezzate e innumerevoli tragedie nel nostro bar sport. Come l’abbiamo fatto è un discorso più complicato: un paio di tipi strambi sono andati in tv a dire che Putin è stato provocato dall’avventurismo atlantico-occidentale, o che armare l’Ucraina non ha senso perché il nemico attacca, mentre durante la Resistenza italiana era in ritirata (eh?), o che dobbiamo smettere di dare del mostro allo zar, perché anche noi anni fa, in Iraq, una volta, ti ricordi? Altri tipi, invero non meno strambi, hanno allora decretato l’esistenza di un ampio fronte di svitati pro-Cremlino, di cui per comodità faceva parte chiunque fosse intervenuto con eccessiva cautela e dunque sospettabile di «putinismo».
Da allora è stato un crescendo rossiniano di tweet – centinaia e centinaia, e poi migliaia – che con la guerra in Ucraina non avevano a che fare se non tangenzialmente: punzecchiature agli «elmettisti» (che, se ho capito bene, sono tutti quelli che sarebbero per sostenere attivamente gli ucraini), dispettucci agli «arrendisti» (i quali, se ho inteso nel modo giusto, sono tutti quelli che vorrebbero discutere le concause del conflitto e sperare nella soluzione diplomatica), e la sempiterna divisione a squadre che si spernacchiano senza sosta in shitstorm a cascata: è un gioco, il solito. Solo che stavolta il balocco risulta particolarmente triste e inopportuno, con tre milioni di profughi che hanno dovuto lasciare le proprie case e centinaia di migliaia di assediati senza cibo, acqua e cure mediche.
Intendiamoci: anche a me capita di cadere in questi tranelli, di entrare nel loop della guerra per procura combattuta per gné gné, di perdere di vista che mentre noi cazzeggiamo su Twitter incasellando le idee altrui nel modo più sciocco e superficiale il mondo continua a essere un’altra cosa. Ma in questi giorni ho assistito a vette di tic polarizzanti, di ottusità, di manicheismo ossessivo che mi hanno fatto pentire di aver messo il dito sull’icona blu dell’app.
Le categorie valoriali della stampa italiana
— 𝙰𝚕𝚎𝚜𝚜𝚊𝚗𝚍𝚛𝚘 𝙶𝚞𝚎𝚛𝚊𝚗𝚒 (@AleGuerani) March 13, 2022
Foto 1: basco rosso con stella da komunista, abbronzato, non ha il frigorifero = BRUTTO!
Foto 2: leccalecca da American teenager, bionda, ha anche la lavastoviglie = BELLA! pic.twitter.com/FSDXIRdhfX
Non so perché persone talvolta anche intelligenti, capaci, colte e che avrebbero da dire cose molto più interessanti e stimolanti di cazzate puerili perdano il loro tempo – e la loro serenità, anche – in meccanismi così palesemente drogati e inquinanti. Eppure succede, e in modo sempre più accelerato e incomprensibile. Perché siamo assuefatti alla dopamina che ci dà metterci l’elmetto e fare le pernacchiette con l’ascella? Perché non tiriamo una linea e diciamo: ok, stiamo diventando ridicoli, basta così?
Dopodiché, ovviamente – come tutti – sulla materia del contendere ho le mie idee. E mi sento di dire che il richiamo alla “complessità" (nel senso dell’it’s more complicated than that, quando assume la forma di una pregiudiziale retorica) dovrebbe valere sempre: non è solo la politica estera della Russia di Putin a meritare spiegazioni più lunghe e sfumate di ciò che entra in un tweet o una storia Instagram, ma pressoché ogni cosa su cui ci accapigliamo ogni giorno, dalle identità sociali alla decostruzione del linguaggio, dalle vittime collaterali degli algoritmi alla definizione di nuovi canoni culturali condivisi. Quando lo storico dell’arte Tomaso Montanari passa dalle etichette di «Bolsonaro italiano» a Mario Draghi e «Repubblica delle Banane» per l’Italia a complessi e cavillosi distinguo sulla legittimità di definire «Resistenza» quella ucraina, devo ammettere che faccio fatica a credere alla sua svolta pro-complessità. E lo stesso vale per tanti altri, sia d’accordo che in disaccordo con lui.
La situazione in Ucraina così “complessa”, almeno al momento, non è: un invasore ha schierato l’esercito per conquistarla, la sta bombardando da quasi un mese, ha distrutto ospedali e rifugi colmi di persone stremate. Chissenefrega se gli americani hanno fatto cose simili ma diverse in Iraq vent’anni fa: andavo alle medie, vent’anni fa. E già allora, credo, sarei stato in grado di condannare moralmente entrambe le cose.
Credo anche che l’isteria collettiva non tenga costitutivamente conto del dato di realtà di questi giorni, forse a volte per esorcizzarne la portata di orrore. Quando i lavoratori dell’aeroporto di Pisa si rifiutano di caricare le armi dirette in Ucraina per non avallare «il clima di guerra nel quale ci sta trascinando il governo Draghi», non considerano che la guerra appena più a est di qui c’è già, e non sotto forma di «clima», ma negli attacchi quotidiani patiti da settimane da milioni di persone innocenti. Per come la vedo, non dar loro una possibilità di difesa, in una guerra in cui anche i civili sono sistematicamente presi di mira, non significa soltanto fargli rischiare la pelle, ma anche togliere al loro Paese la possibilità di fiaccare l’esercito invasore arrivando più “forte” ai negoziati per la pace. Nella realtà gli elmetti e la diplomazia convivono. Anzi: gli uni hanno bisogno dell’altra, e viceversa.
Negli Stati Uniti si usa una bella espressione, che per anni non mi sarei mai sognato di usare in una filippica di critica serrata ai social network (strumenti che ho sempre usato, e a cui mi sono anche sentito legato, per così dire). È touch grass, letteralmente “tocca l’erba”: vai fuori, fai una passeggiata, smetti di ossessionarti su ciò che leggi e rumini online, torna alla realtà. Ecco, al duemillesimo tweet su quelli che si arrendono e quelli che si mettono l’elmetto in testa, la uso con piacere: touch grass, everybody.
Disinformazione con caratteristiche cinesi
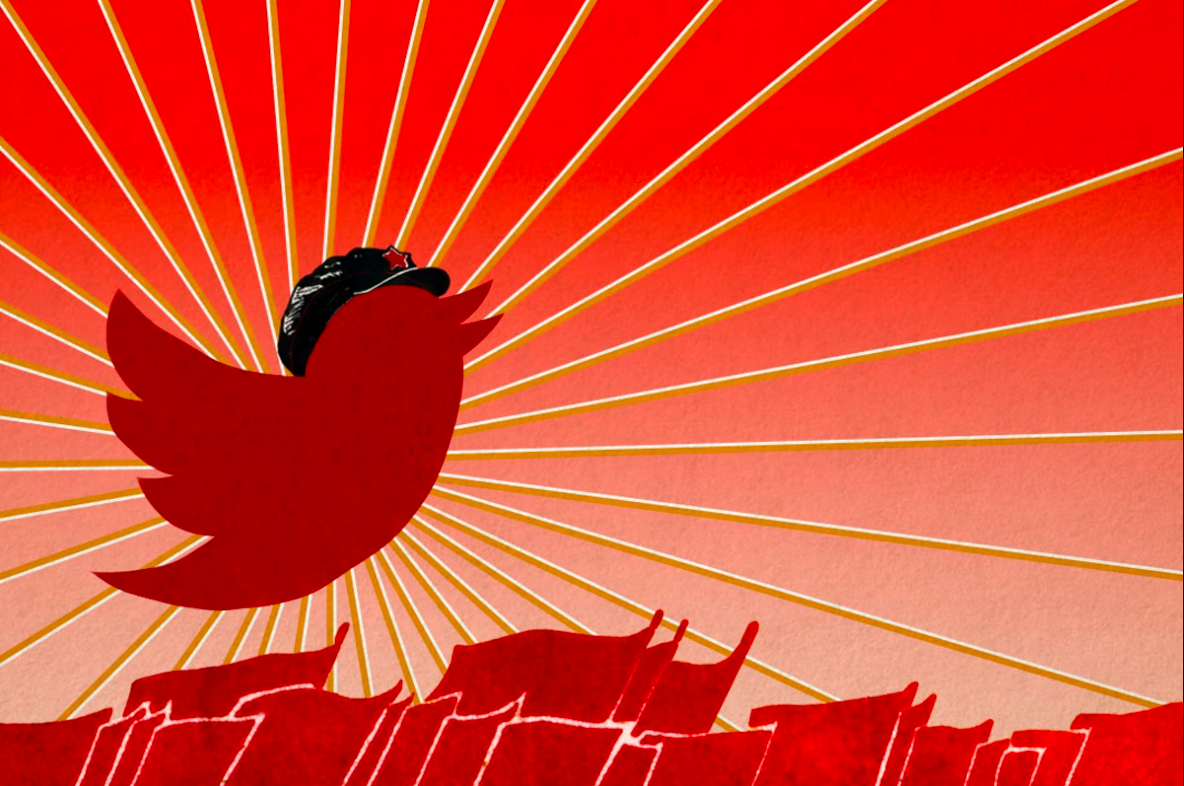
Un ruolo fondamentale, e in Italia poco dibattuto (se si escludono le nobili eccezioni di Simone Pieranni del Manifesto e pochi altri) nella info war parallela al conflitto in Ucraina è quello della Cina: anche a prescindere dal discusso (e temuto) rifornimento di armi alla Russia, Pechino si trova in una posizione difficile, e non ha mai nascosto di trovarsi a disagio di fronte alle politiche di un alleato che finora non ha smesso di sostenere, seppure con una certa distanza.
È interessante vedere come la popolazione cinese parla del conflitto, perché è un campo in cui si scoprono cose interessanti. A partire da questo thread di Han Yang, un cittadino cinese invitato a prendere parte a un gruppo WeChat per suoi connazionali espatriati in Australia: è lunghissimo ma vale la pena leggerlo bene, perché mostra come funzionano le ruote dei meccanismi della censura e del condizionamento di stato nel Paese più popoloso del mondo.
Hang usa il termine pinkies (“mignolini”) per riferirsi ai cyber-propagandisti di Pechino, quelli che ripetono pedissequamente la linea ufficiale del partito diffusa dai media di stato. Nel caso specifico, dunque, fanno da ripetitori della propaganda russa: ripostano video dei massimi organi dell’informazione cinese con soldati russi che dividono il loro cibo con bambini ucraini, o di soldati ucraini fatti prigionieri che chiedono scusa per le loro malefatte. O ancora si indignano di fronte alla registrazione (ovviamente finta) di una chiamata con cui il presidente Zelensky avrebbe organizzato la fuga all’estero della sua famiglia, eccetera.
They marvel at Russia’s propaganda skills with a video about Russian soldiers sharing food with Ukrainian children or Ukrainian POWs reflecting on their sins at a memorial for children killed by the evil Ukrainian Government…. Note these are all from Chinese state media accounts pic.twitter.com/1fMMoL5tvf
— 杨涵 Han Yang (@polijunkie_aus) March 6, 2022
Contenuti del genere sono sempre più diffusi nell’enorme web cinese anche perché, ha spiegato il giornalista Tony Lin, i social media hanno fatto una scelta di business incoraggiando il nazionalismo: dato che una censura capillare e spietata colpisce pressoché ogni altra posizione e contenuto, puntare forte su un’utenza più giovane e politicamente patriottica si è rivelata una scelta vincente. Tanto che le principali piattaforme oggi incoraggiano la delazione fra gli utenti per segnalare chi “sgarra”, contribuendo a generare un panorama discorsivo sempre più chiuso, allucinato e disinformato.
Every platform adjusted: WeChat public account boom created a lucrative industry for ppl who want to capitalize on nationalism. Douban’s little pinky groups proliferated. 鹅组 became a hub for reporting and doxxing ppl. Sensitive titles are banned from rating there, too. 3/
— Tony Lin 林東尼 (@tony_zy) March 10, 2022
Nelle infosfere cinesi proliferano anche i wolf warriors: figure istituzionali – spesso diplomatiche – che fanno la voce grossa sui social media occidentali (di solito: Twitter), ricavandone copiose lodi e clout su quelli di casa propria. Il campione della specialità è l’ex direttore del ministero degli Esteri Lijian Zhao, che su Twitter ha più di un milione di follower conquistati a suon di sbruffonate, ma non è affatto l’unico.
Se ci aggiungi che i media di stato cinesi hanno recentemente condiviso – e, per diretta conseguenza, fatto condividere a centinaia di milioni di persone – il discorso in prima serata dell’host trumpian-putiniano di Fox Tucker Carlson che propaganda la balla dell’intervento russo in Ucraina motivato dalle ricerche sui virus nei laboratori di Kiev, e che a loro volta – come ha spiegato Eliot Higgins di Bellingcat – i russi pescano le loro linee narrative (per così dire) direttamente dalle nicchie online dei cospirazionisti... beh, diciamo che è un mondo difficile. E che considerare i social un Eden di libertà e rappresentazione vuol dire quantomeno avere una prospettiva molto limitata.
Ah: una gran bella newsletter sulla quotidianità digitale cinese – a cui questo breve testo deve molto, peraltro – è Chaoyang Trap. Te la raccomando caldamente.
Altre news dal fronte
- Il signor Vladimir Putin ha detto che l’occidente vuole «cancellare» la Russia, facendo drizzare le antennine a chiunque abbia passato più di un quarto d’ora su Twitter ultimamente: non è un caso e non è la prima volta che il termine viene buttato lì (l’aveva fatto, pochi giorni fa, anche il direttore dell’intelligence internazionale russa Sergey Naryshkin). Il fatto è che [rullo di tamburi] Putin ha ragione; semplicemente ha usato un plurale maiestatis che poteva evitare: si cerca di cancellare lui, non la Russia, e secondo Helen Lewis è una buona cosa.
C'è differenza, si scopre, tra l'invocazione iperbolica della "violenza" su Twitter e la violenza vera e propria, quella letterale.

- Gruppo repubblicano di studenti dell’Università della California-Los Angeles che invita Putin a parlare nel suo campus: molto ridere (a denti stretti, si intende);

- La storia complicata di come Red, l’ultimo lungometraggio Pixar, è rimasto invischiato nel gorgo delle culture wars;

- Un pacifico incontro a tema libertà di espressione alla Yale Law School è finito malissimo, pur senza alcuna apparente tensione tra i suoi partecipanti: contestazioni, urla, spinte, minacce sono arrivati tutti da un gruppo di contestatori appena un po’ troppo su di giri. Il panel doveva essere un modo di «dimostrare che un ateo di sinistra e un cristiano conservatore potevano trovare un terreno comune sulle questioni della libertà di parola», ha scritto il sito conservatore FreeBeacon.