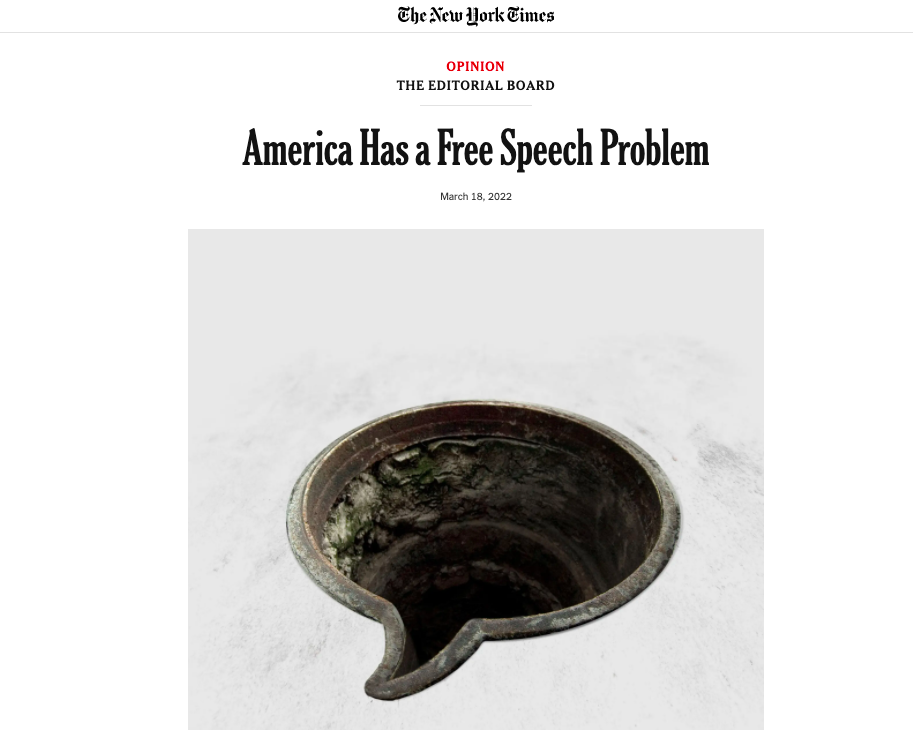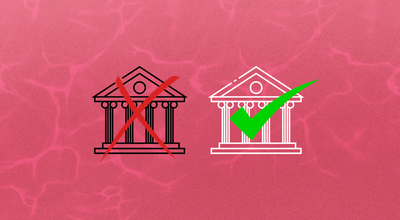L’editoriale della discordia
Il New York Times ha pubblicato un articolo del suo Editorial Board, cioè le 14 persone che decidono le linee condivise della sezione Opinion del giornale: si intitola “America Has a Free Speech Problem” e dice testualmente, nelle sue prime righe, che:
Gli americani stanno perdendo il possesso di un diritto fondamentale dei cittadini di un paese libero: il diritto di dire ciò che pensano e di esprimere le proprie opinioni in pubblico senza timore di essere umiliati o evitati.
Secondo il Times, questo clima di aperta ostilità al dibattito, e di arretramento generalizzato della libertà di espressione, è da imputare «in larga parte» al fatto che «la sinistra e la destra sono intrappolate in un loop distruttivo di condanna e recriminazione attorno alla cancel culture».
Molti a sinistra si rifiutano di riconoscere che la cancel culture esiste, credendo che coloro che se ne lamentano stiano offrendo copertura ai bigotti per spacciare incitamenti all'odio. Molti a destra, nonostante tutto il loro ragliare sulla cancel culture, hanno abbracciato una versione ancora più estrema della censura come baluardo contro una società in rapido cambiamento, con leggi che vieterebbero i libri, soffocherebbero l’insegnamento e scoraggerebbero la discussione aperta nelle classi.
Il clima, dice il board, ha reso le persone «incerte sui limiti della libertà di parola»:
Molti sanno di non dover dire cose razziste, ma non capiscono cosa possono dire sulla razza o cosa possono dire a una persona di una appartenenza etnica diversa dalla loro. Attaccare le persone sul posto di lavoro, nel campus, sui social media e altrove quando esprimono opinioni impopolari in buona fede è la pratica di una società chiusa.
L’editoriale ha una seconda parte dedicata alle leggi repubblicane «che vieterebbero i libri» o costringerebbero le scuole primarie a vietare discussioni di temi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere (è il caso del recentissimo “Don't Say Gay Bill” della Florida), ma buona parte dei suoi ragionamenti si rivolge al mondo progressista: «Le persone dovrebbero essere in grado di presentare punti di vista, porre domande e commettere errori, e anche di assumere posizioni impopolari ma in buona fede su questioni su cui la società sta ancora lavorando, il tutto senza temere la cancellazione», per citare ancora dal testo.
If you doubt for a moment The Times' turn to sympathy with the white-right, let this end those doubts: a yes-but attack on the left for making white people uncomfortable. Here is white victimhood, naked to behold. 5/ pic.twitter.com/xKlurZ8Ree
— Jeff Jarvis (@jeffjarvis) March 18, 2022
Forse per questo, su Twitter l’articolo ha avuto l’effetto di uno tsunami: Jeff Jarvis, che ha 67 anni, è bianco, e frequenta da tempo il gotha del giornalismo statunitense, ha scritto in un thread molto condiviso che quello del Times è un atto di «vittimismo bianco alla luce del sole»: si preoccupa dei «bianchi messi a disagio», dice Jarvis; parla dal pulpito della «posizione di potere che il giornale ha ricoperto a lungo», e il suo vero problema è che ora non riesce a regolarsi per prendere parte a una «conversazione più ampia» (strano, dato che alcuni dei più ferventi partecipanti a questa conversazione lavorano o hanno lavorato al Times). Secondo Jarvis, internet ha «permesso di ascoltare voci troppo a lungo non ascoltate dal gatekeeping dei media maschi e bianchi» (cioè quelli come Jarvis), e i polverosi gatekeeper come il Times «detestano» questa cosa.
Leggendo l’articolo, devo dire che anche io ho avuto un paio di momenti di alzata di sopracciglio: il primo, per come il suo incipit rischia di suggerire un’equivalenza formale tra alcune proposte repubblicane di leggi liberticide e i casi di “cancellazione” online, anche se lo fa con un’angolazione sensata, cioè usando la lente socio-culturale della libertà di espressione; il secondo, in corrispondenza di un paragone imperniato sul riferimento alla freedom of speech della Russia di Putin, per me del tutto evitabile (e su questo do ragione a Jarvis).
Ma in generale, mi ha colpito notare l‘esatta rispondenza delle critiche raccolte da questo editoriale con quelle incassate pochi giorni fa da un intervento analogo, e accolto in modo pressoché identico dalle stesse persone: quello della laureanda Emma Camp che lamentava di un clima ostile al dibattito e alla diversità di opinioni nel suo college.
In entrambi i casi, le reazioni più pavloviane si sono concentrate su quello che a me sembra un singolo possibile caso specifico: un/a intollerante di destra che viene pubblicamente svergognato/a per aver usato epiteti razzisti, offeso minoranze o insultato violentemente categorie di persone non maschie, non bianche e non etero. Non c’è però traccia del fatto che l’Editorial Board del New York Times stia perorando in alcun modo la causa di questa ipotetica persona razzista, misogina, omofoba o abilista: anzi, l’editoriale parla a più riprese di errori commessi «in buona fede»; cioè di peccati veniali, che sono cose diverse dai proclami razzisti e dagli atti di discriminazione.
Secondo il giornalista e fondatore di Press Watch Dan Froomkin – già attivissimo giorni fa nel caso Camp, fino al punto da affermare falsamente che la studentessa avrebbe fatto parte di un «network conservatore» – il quale poco sorprendentemente ha fatto sua questa interpretazione molto selettiva, l’intolleranza semmai andrebbe svergognata di più di quanto non succeda già. È il paradosso della tolleranza di Karl Popper, no?
Beh, nì: essere intolleranti nei confronti di chi è intollerante è una cosa molto diversa da essere intolleranti tout court, scambiando errori innocui per esecrabili violenze, costruendo intere reputazioni su segnalazioni seriali da burocrati zelanti o dando innocui malcapitati in pasto alle casse di risonanza algoritmiche. Queste ultime cose – e tutto ciò che c’è dietro – con i giochi di potere e il «vittimismo bianco» non c’entrano nulla: non a caso, con tutti i suoi limiti l’editoriale ha il merito di citare quello che per me è il vero nocciolo del discorso: «Rendere internet un posto più vivibile non sembra in cima all'agenda di nessuno, e certamente non di quelle della maggior parte delle società tech che lo controllano», vi si legge.
Infine, ci sarebbe che il New York Times, al di là di ogni aspetto opinabile delle conclusioni a cui arriva, in quell’articolo cita i dati verificati di alcuni sondaggi nazionali: solo il 34% degli americani pensa che i suoi connazionali godano di una libertà di espressione indiscriminata e ottimale; per l'84% degli statunitensi il fatto che alcuni di loro non sentano di potersi esprimere liberamente è un problema «molto serio» o «piuttosto serio»; solo il 21% degli americani si sente più a suo agio a parlare di temi politici rispetto a dieci anni fa; e anche più di metà delle persone afroamericane sondate non ha la percezione di una serena libertà di discussione rispetto all’ultimo decennio.
Ecco la rivoluzione contro gli zar del gatekeeping, ecco l’internet invariabilmente salvifico e liberatore. Forse il Times sta davvero virando a destra, per carità: nel qual caso sarò il primo ad allontanarmici. Ma per ora sappiamo solo che ha pubblicato due editoriali di critica a un clima culturale giudicato oppressivo o quantomeno migliorabile da moltissimi statunitensi. Se nella vita facessi il detective, direi che per costruire un caso servirebbe qualche prova in più.
#CultureWarsMeets: Jennifer Guerra ⬇

#CultureWarsMeets torna dopo qualche settimana: questa volta mi ha permesso di scambiare qualche opinione con Jennifer Guerra, autrice de Il capitale amoroso (Bompiani) e Il corpo elettrico (Tlon) e stimata collega che ha scritto tanto dei temi di cui ci occupiamo da queste parti.
Il sottoscritto in grassetto e l’ospite in regular font, come di consueto. E grazie a Jennifer per l’interessante discussione.
⪢ Eccoci! Ho appena finito di leggere il tuo saggio pubblicato nella collettanea di Utet, Non si può più dire niente?: sono d’accordo su diverse cose che sostieni nel testo, e meno su altre. Nello specifico, mi convince la tua analisi sul politicamente corretto come «frame di destra», almeno per come se ne parla nel mainstream, specie quello italiano. Quello su cui invece non mi trovi d’accordo è la caratterizzazione della materia del contendere riguardo alla cosiddetta “cancel culture” nella cornice unica dello «sradicare fenomeni discriminatori». Cioè, se capisco bene, dici: l’attivismo di cui discutiamo non fa mica del moralismo tanto per farlo, perché dalle sue linee di azione deriva il miglioramento materiale della condizione di vita delle persone oppresse.
Ecco, di questo non riesco proprio a convincermi del tutto. So bene che tanti progetti di lotta e di pressione delle minoranze (anche sui social) si occupano precisamente di questo, cioè di decostruire, come si dice, situazioni e questioni apparentemente secondarie della vita quotidiana e spiegare alle maggioranze come rendono la loro vita difficile. Sulle piattaforme digitali di cui siamo vassalli però non ci sono solo le istanze di primo livello: c’è anche come vengono processate (e fraintese) dalle camere dell’eco, dai pubblici allargati, dalla decontestualizzazione e polarizzazione algoritmica. Ovvero, per arrivare al dunque, e a due esempi celebri: che discriminazione sradica prendersela con un tizio a caso che ha fatto un post a caso contro un manifestante (bianco) di Black Lives Matter che ha dato fuoco a un municipio? O con un ricercatore di sinistra che ha twittato una ricerca secondo cui alcune violenze delle proteste avrebbero potuto favorire elettoralmente Trump?
Tanto più – e scusa la verbosità: finisco – che a me la guerra in Ucraina sembra aver ricreato sui social le stesse dinamiche tossiche che ho in mente quando ragiono su questi temi: da una parte chi ha strenuamente a cuore gli ucraini, oppure la pace, oppure whatever, dall’altra chiunque si possa incasellare superficialmente come eretico rispetto alla visione monodimensionale del clan di appartenenza: persone che quindi, in questa logica perversa e manichea, è bene segnalare e colpire a prescindere dalle loro colpe. Ti torna?
Mi torna perché credo che gli stronzi esistono da tutte le parti, nel senso che anche se certe rivendicazioni sono – usiamo questo termine – giuste, le modalità della contestazione possono essere sbagliate. Così come le persone che le portano avanti genuinamente cattive. Io odio il call out, penso di non averne mai fatto uno in vita mia, non mi sognerei mai di attaccare una persona specifica a mezzo social, ancor più se una persona a caso, che ha un potere limitato di incidere sulla realtà. Ma cerco comunque di sforzarmi di capirne le ragioni, di mettermi in discussione e spesso mi accorgo che sono d’accordo con i contenuti ma non con la forma. Purtroppo nella maggior parte dei casi, la reazione di chi lo subisce è di vittimismo ingiustificato (“Aiuto, delle quindicenni su Twitter mi hanno dato del maschio bianco etero!”) o di totale chiusura. Forse questo è il limite intrinseco del call out, ne parlo anche in questo vecchio articolo.
Ti dirò di più. Mi è capitato di essere dalla parte sbagliata della barricata, di essere oggetto di call out, e non da parte di troll di destra, ma da parte di attiviste femministe con cui magari ero pure in buoni rapporti. È stato brutto e in alcuni casi ritengo pure un po’ gratuito, ma alla fine mi è servito ad aggiustare il tiro, a farmi delle domande che forse non mi sarei posta altrimenti. Certo, è un modo brutale e questo non lo nego. Ma come cerco di spiegare nel mio contributo per il libro di Utet, c’è sempre un legame tra le questioni di “correttezza” e quelle di “giustizia”. Non dobbiamo illuderci che il cambiamento si conquisti con grandi azioni eclatanti, non è che c’è o Martin Luther King o Jim Crow. In mezzo c’è una terra di nessuno, fatta di strumenti più o meno leciti, efficaci, utili. Che possono essere maneggiati tanto da persone capaci e consapevoli quanto da stronzi con cattive intenzioni che hanno solo voglia di distruggere gli altri.
⪢ Questo mi sembra un buonissimo punto, anche se in tutta onestà quel che trovo difficile e di importanza centrale è proprio approdare a quel “farsi delle domande”: succede davvero? Dando per scontato (conoscendo le tue idee e quel che scrivi mi sorprenderebbe il contrario) che quando sei stata oggetto di call out non solo tu non avessi inneggiato al Reich vestita da Goebbels, ma nemmeno ti fossi macchiata di discriminazioni gravi, quelle attiviste di cui parli non avrebbero in fin dei conti fatto meglio a parlarti in privato – o in un commento con meno “reach” – del tuo errore veniale? E su un piano più generale: secondo te davvero il call out è un modus operandi che può portare a riflettere e farsi domande? A me sembra più che altro un’autostrada verso l’antagonizzazione e l’incomunicabilità.
Una parentesi aneddotica: qualche anno fa uno scrittore e traduttore, anche con un suo seguito, mi ha dedicato una “lettera aperta” tutta imperniata su indubitabili e sacrosanti proclami di lotta al sessismo imperante nel campo editoriale e sui social network; poche ore prima una scrittrice e collaboratrice di Internazionale, Violetta Bellocchio, aveva pubblicato un articolo su una sua esperienza soggettiva alla stazione milanese di Rogoredo di cui forse ti ricordi, che era stato accolto col solito surplus di sberleffi – e qualche commento osceno e borderline misogino – per via del suo titolo un po' esagerato. I commenti osceni di quel giorno me li ricordo tutti, ma quelli che avevo postato io non solo non lo erano: erano due placide battutine su un pezzo mal riuscito, senza alcun riferimento a chi l’aveva scritto. Al limite potevano non far ridere, ma di certo non erano sessiste. Era il 2016 e ai tempi (detto sospirando: come si stava bene, col senno di poi!) nessuno parlava ancora di “cancel culture” e altre amenità, ma quello scrittore mi aveva tirato in mezzo in una cosa con cui non avevo nulla a che spartire, aveva taggato i miei capi di allora (ufficialmente per «una riflessione», ça va sans dire) e insomma, si era fatto bello a mie spese.
Questo è un caso limite, e sarei folle o almeno confuso se pensassi che tutti i call out sui social si basano su accuse inventate di sana pianta: però credo che l’esperienza mi sia servita per capire cosa può succedere quando buttare a mare un malcapitato – quale poteva essere il me venticinquenne redattore junior che scherza sull’articolo di Bellocchio – vale “punti clout” più facili e immediati di impegnarsi per cambiare qualcosa. Finché sui social sarà così facile – anzi, direi incoraggiato – costruirsi seguiti basati sul solo puntare il dito, personalmente vedo sempre più annegamenti all’orizzonte.
Ti dirò, nel mio caso io rifarei esattamente la stessa cosa per cui sono stata “called out”, perché sono ancora convinta di aver fatto la cosa giusta, ma quello che cambierei è il modo in cui l’ho fatta. Capisco che senza un minimo di contesto non si capisce granché, ma vorrei insistere sul fatto che questo call out sicuramente non mi ha resa una persona migliore, ma mi ha portata a riflettere in qualche modo, fosse anche solo su quanto è facile pestare merdoni. Forse ha contribuito anche il fatto che mi sono scusata (anche se le mie scuse non sono state accettate) e tutto è stato breve e abbastanza indolore. Poi ho anche capito che la persona che mi aveva fatto call out è fatta così, e pazienza. La regola che mi sono data, visto che mio malgrado occupo uno spazio ingrato e che non vorrei occupare che è quello del “femminismo su Instagram”, è che io cerco sempre di costruire e non di distruggere. Se vedo distruzione, passo oltre. Questo significa non solo evitare di fare call out, ma anche di difendere pubblicamente chi ne è oggetto, e ti assicuro che non è bello sentirsi sempre tirare per la giacchetta.
Come dici tu, c’è un sacco di gente che vuole costruirsi una carriera cercando di distruggere gli altri. Quello che mi stupisce, però, è che è proprio chi si erge a paladinə contro il wokeismo, l’attivismo performativo e tutta la compagnia, a comportarsi nel modo peggiore. Potrei farti un bel po’ di esempi di persone che usano il call out per lamentarsi del call out.
Il tuo episodio comunque mi ha ricordato di quella volta che una nota Terf aveva chiamato il direttore di The Vision, dove lavoravo da meno di un mese, per dirgli che la mia carriera era finita perché l’avevo associata al femminismo trans-escludente in un articolo. Tra l’altro non era un post o un tweet, ma un articolo con fonti e argomentazioni. È il suo modus operandi: anziché farti call out pubblico chiama i tuoi superiori o ti minaccia di querela. Non credo sia mai riuscita a cambiare la carriera di nessuna, ma forse a questo punto sono meglio un paio di giorni di shitstorm e poi passa tutto. Mi sembra che tu te la sia cavata bene nonostante questo episodio, no?
⪢ Quest’ultima cosa che racconti è atroce, e pur conoscendo i metodi del personaggio di cui parli (ironicamente aveva minacciato anche me, anche se per questioni non-Terf) penso che rappresenti con drammatica fedeltà un certo modo di intendere il giornalismo in Italia. Dopodiché no, certo, a me è andata bene dopo quell’episodio, ma come si potrebbe dire di uno che è scivolato a bordo piscina e ha mancato il cemento con la testa per qualche centimetro. Ti parrà una metafora esagerata, ma ero giovane, sconosciuto (cosa che continuo a essere, beninteso, ma forse meno di prima) e facilmente “colpibile”: coinvolgere i miei superiori e additarmi con accuse così gravi e squalificanti – che sono doppiamente tali nel nostro settore di riferimento, va notato – magari non mi avrebbe mai rovinato per sempre la carriera, ma poteva tranquillamente renderla più difficile, chiudermi delle porte, inimicarmi delle persone influenti. Banalmente non avrei mai potuto aprire un progetto come quello che gravita attorno a questa newsletter, in quel periodo.
Ora vorrei però lasciare a te l’ultima parola su uno dei temi principali della settimana, cioè il famoso (“famigerato”?) editoriale del New York Times sulla cosiddetta “cancel culture”. Ce ne sarebbero di cose da dire – io ho provato a mettere i miei 2c qui sopra, ma mi interessa sapere cosa ne pensi tu e perché.
Onestamente non penso sia un cattivo editoriale, diciamo che non vorrei mai più leggere un editoriale sulla cancel culture in generale. Secondo me è giusto mettere a confronto i due fenomeni, leggi e cancel culture “da social”, perché quelle leggi arrivano proprio da quelli che per primi si lamentano della cancel culture.
Come dicevo in un mio post su Ordo Iuris che avevi commentato anche tu nella newsletter, è interessante vedere come le organizzazioni più reazionarie e liberticide si stiano “vendendo” come protettori della libertà di espressione. Ho anche pensato, leggendo, che la fissa degli americani per il free speech ha sempre qualcosa di incomprensibile ai miei occhi.
Altre news dal fronte
- Una quercia di quasi 200 anni che pare fosse stata piantata direttamente dal romanziere russo Ivan Turgenev è stata squalificata dal premio European Tree of the Year come atto politico contrario all’invasione russa in Ucraina. Rileggi piano;

- Solita cascata di tweet e contro-tweet anche sulla fondatrice del 1619 Project Ida Bae Wells, che ha detto e ripetuto che lasciare la mancia ai camerieri negli Stati Uniti è un lascito dello schiavismo;

- Il mese scorso l’autrice Lauren Hough era stata nominata ai premi letterari Lgbt+ Lambda, nella categoria “Lesbian memoir”; poi ha difeso la collega e amica Sandra Newman da alcune accuse di transfobia su Twitter – non so se ricordate: Newman era quell’autrice ehm, transfobica perché aveva immaginato nel suo nuovo libro un mondo ipotetico privo di uomini senza, ehm, specificare se comprendeva le persone trans – e un solerte inviato del premio letterario le ha spiegato che il suo riconoscimento è stato ritirato.