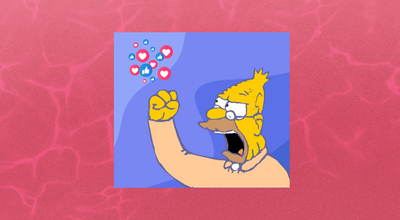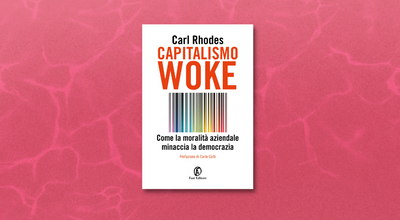È giugno, e come succede da qualche anno anche in Italia si inizia a recepire la rilevanza del Pride Month, il mese di eventi e iniziative che celebrano la ricorrenza dei moti di Stonewall, il locale del Greenwich Village newyorkese in cui nel 1969 le persone omosessuali si ribellarono a una retata della polizia, dando una nuova, fondamentale spinta simbolica e motivazionale all’attivismo queer.
Purtroppo, a festeggiarlo non sono solo persone che spesso hanno vissuto vite difficili, talvolta disapprovate e ostacolate addirittura dai propri famigliari, e quasi sempre complicate da sistemi sociali che non le riconoscevano: lo fanno anche scaltri direttori marketing e Ceo. È il fenomeno che in gergo chiamiamo rainbow washing, (dove l’arcobaleno è, ovviamente, quello della bandiera Lgbt+), cioè lo sfruttamento a fini consumistici del Pride.
Il rainbow washing si verifica quando l’azienda che segui su Twitter o Instagram (ma poi abbi pazienza, per inciso: perché mai seguire un’azienda sui social? Sorvoliamo) cambia la sua immagine aggiungendovi una scala di colori arcobaleno. Si trattava, almeno in origine, di una dichiarazione di “vicinanza di valori”: io, venditore di manghi e papaye, ci tengo a far sapere a te, compratore di manghi e papaye, che nella mia visione del mondo le persone non possono essere discriminate per le loro preferenze sessuali. Una cosa fondamentalmente buona e giusta, ecco.
Poi però è inevitabilmente diventato un modo di fare soldi, la quintessenza del conformismo capitalista. Qualcuno – come l’Harvard Business Review – ha fatto notare che «molti membri della comunità Lgbt+ sono stufi del “capitalismo rainbow”, un termine coniato per descrivere come i simboli queer vengono branditi dalle compagnie per massimizzare il consumismo senza portare a miglioramenti significativi per le persone Lgbt+». E la cosa non sorprende, diciamo.
Posto raramente meme, eppure (via Marxist Memes) pic.twitter.com/ViUhAOO3Pj
— Davide Piacenza (@Davide) June 19, 2022
Così com’era successo durante le proteste di Black Lives Matter del 2020, quando i grandi brand hanno mostrato vicinanza agli afroamericani postando quadrati neri, per poi continuare placidamente a essere guidati da board monocolori («le aziende devono diventare il cambiamento di cui stanno twittando», aveva chiosato giustamente Mark Ritson), il Pride per molte direzioni marketing è solo un altro modo di entrare nella conversazione e fare soldi. Altro che ally, insomma, e altro che support.
Il punto è – anche – che i social network sono ingegnerizzati appositamente per agevolare questi comportamenti ipocriti e dannosi. E, peggio ancora, per certi versi ci hanno resi tutti aziende in cerca di incrementi esponenziali dei nostri numeri: quando vedete un o una influencer “inclusivo/a” che inframmezza le sue storie di sponsorizzazioni di prodotti, il problema non è (solo) che quella persona sta confondendo il suo presunto attivismo – un’attività di per sé libera, critica e non legata a centri di potere economico – col marketing, ma che quelle logiche spesso regolano anche il resto della sua produzione quotidiana.
Parafrasando la citazione di pocanzi, anche gli influencer dovrebbero diventare il cambiamento di cui postano. Ma non lo faranno, perché agiscono su piattaforme private pensate per sfumare i confini tra compagnie con prodotti da vendere e persone con pubblici da costruire: nella dimensione parallela dei tweet e le Storie non conta l’attività ma la performatività, cioè mostrare agli altri da che parte stai. E, peggio ancora, c'è una concorrenza (l’uso del termine non è casuale) spietata: abbiamo introiettato le logiche del consumo e la cultura del mercato, e le applichiamo alla bell’e meglio alle lotte sociali e ai diritti civili, che pure avrebbero bisogno di ben altro per prosperare.
Quella in cui viviamo è l’epoca storica che ha reso l’adesione a un set di valori/visioni del mondo un’inezia, anzi un atto pigro e metodico come il dichiararli su un palco, seguendo alla lettera banali liturgie da setta para-religiosa. Il capitalismo arcobaleno, in tutto questo, ringrazia commosso: il suo palco ce l’aveva già da tempo immemore, ma non poteva certo immaginare che saremmo stati noi a esibirci gratuitamente al posto suo (sul tema segnalo anche un interessante scritto di Irene Graziosi).
L’altro giorno su Twitter è finito questo video, tratto da una campagna di Netflix.
Ma che non-problema è? La domanda era assolutamente "neutra". Netflix che sguazza in sta roba pic.twitter.com/RumIdWUj5q
— Dax (@Daxest) June 18, 2022
Il problema, come segnala Dax – il quale, detto en passant (anche se la sola idea di doverlo precisare è fastidiosa) non è uno che sguazza nel privilegio cis-etero – è effettivamente un non-problema, ma Netflix ci si è buttata a pesce, perché quel linguaggio, quella posa, quell’approccio da catechesi a cui è improntato il video oggi, beh, convengono. Anzitutto economicamente.
La banalizzazione è sempre stata un fulcro della pubblicità: nessun cumenda imprenditore a capo di un’azienda di solventi della Bassa Padana ha mai cercato di avviare un dibattito sulla sostenibilità ecologica degli agenti chimici, per dire. Il problema di oggi, però, è che quella semplificazione intrinsecamente connessa al marketing è diventata nostra, cioè è passata dal prodotto al consumatore, che sempre più spesso non distingue tra la complessità critica delle idee e la semplice mediocrità interessata di chi opera a fini di lucro.
Non so cosa ne pensi tu, ma a me non sembra una grande cosa, in generale. Anzitutto perché tutte quelle aziende danno l’idea di chi potrebbe passare tranquillamente a sostenere qualsiasi altra cosa, se domani il vento soffiasse in una direzione diversa (e l’hanno fatto, in altre epoche e con altri venti).
Nel dubbio, meglio replicare sempre con quel vecchio adagio caro agli scettici: non compriamo niente, grazie.
Altre news dal fronte
- Bob Bakish, capo di Paramount, ha detto che la società che dirige non intende rimuovere contenuti dal suo nuovo servizio streaming in abbonamento:
Non credo nella censura dell’arte prodotta in epoche diverse, penso sia un errore. È tutto on demand: non devi guardare nulla che non ti vada di guardare.

- La Fina, federazione internazionale del nuoto professionistico, ha deciso di escludere le atlete transgender dalle competizioni femminili, dopo alcuni casi di vittorie diventati oggetto di polemiche, a partire da quella della statunitense Lia Thomas, trionfatrice ai campionati universitari americani, secondo i critici per un vantaggio di natura biologica. Al vaglio dell’organizzazione c’è la creazione di una nuova «categoria aperta» inclusiva per le persone trans;

- L’ultimo numero del New York magazine ha una cover molto bella che recita «Canceled at 17»: racconta la storia di Diego, un adolescente al liceo la cui vita è stata rovinata da una serie di accuse cresciute a dismisura sui social network e nel suo giro allargato di conoscenze, dopo un errore stupido e oggetto di rimorso (aveva mostrato una foto intima della sua ragazza ad alcuni amici a una festa, è finito in una lista di «abuser seriali» nei bagni della scuola e ha perso ogni amicizia). Mi guardo bene dall’usare termini carichi di rimandi pavloviani ideologici per pappagalletti quali “cancel culture”, quando possibile: per quel che mi riguarda bisognerebbe parlare meglio di questi fenomeni, molto prima che dell’etichetta da affibbiargli;

- Newsletterati è una lista di link, ma anche una specie di Avengers delle newsletter italiane. Culture Wars è onorata di farne parte, insieme a tanti altri progetti interessanti: dagli un’occhiata.
(aggiungi l’indirizzo ai tuoi contatti, altrimenti rischi che la newsletter finisca nella cartella Spam)