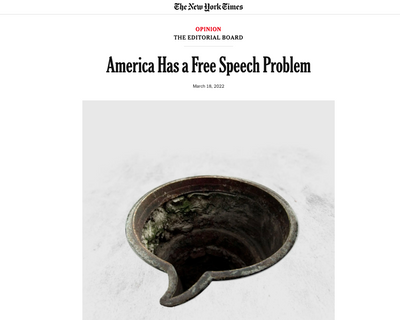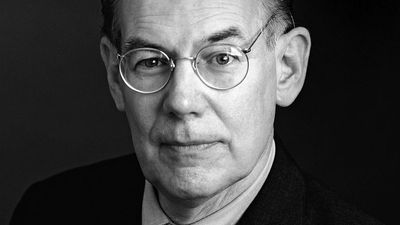«Un attacco premeditato»: così sono state definite dagli inquirenti le dieci coltellate inferte da Hadi Matar, un uomo ventiquattrenne di fede musulmana del New Jersey, allo scrittore Salman Rushdie poco prima di un incontro letterario programmato per la mattina del 12 agosto a Chautauqua, nell’ovest dello Stato di New York.
Matar ha acquistato un biglietto per l’evento a cui Rushdie si apprestava a partecipare, si è recato sul posto in autobus e, quando l’autore dei Versi satanici è salito sul palco, vi si è precipitato iniziando a colpirlo ripetutamente con un coltello (un video girato nella sala mostra alcuni momenti dell’aggressione, e vi si scorge Rushdie disteso in una pozza di sangue).
NOW - Salman Rushdie is stabbed on stage in New York.pic.twitter.com/qFmYE6BC5E
— Disclose.tv (@disclosetv) August 12, 2022
Dopo le prime ore di preoccupazione – l’agente di Rushdie, Andrew Wylie, ha detto che potrebbe perdere un occhio e l’uso di un braccio – ora sembra che l’autore indiano-britannico si trovi fuori pericolo e sia tornato a respirare senza l’ausilio di macchinari medici.
La fatwa che l’ha colpito nel 1989, l’anno in cui è stata pronunciata dall’ayatollah Khomeini («Vorrei informare tutti gli intrepidi musulmani del mondo che l'autore del libro intitolato Versi satanici, così come quegli editori che erano a conoscenza del suo contenuto, sono condannati a morte»), ha sfiorato la sua folle realizzazione per mano di un giovane uomo che al tempo dell’uscita dei Versi satanici – il romanzo considerato blasfemo dal radicalismo islamico che gli è valso la condanna a morte – non era nemmeno nato.
Si è notato da più parti che il tentato assassinio ha generato reazioni miti o direttamente assenti in molti progressisti (tra le poche eccezioni encomiabili in Italia, io applaudo quelle di Erri De Luca ed Enrico Letta). Forse perché, come accade sempre più spesso nella macchina polarizzante delle piattaforme, l’accaduto non si presta al sostegno di una narrazione orientata, senza sfumature ed edificante, perfetta per accumulare like e prestigio da portavoce. In alcuni casi – ed è un leitmotiv che ritorna nell’affrontare discorsi spinosi che riguardano altre culture – si tace perché si pensa che i vecchi arnesi dell’Illuminismo, a partire dalla libertà di espressione e dal diritto di criticare l’oscurantismo, oggi siano finiti nel cassetto degli attrezzi della peggiore destra. E nessun progressista vuol avere nulla da spartire con gli islamofobi, per rimanere al caso specifico.
Non è un’idea del tutto campata per aria, almeno in superficie. Oggi diversi reazionari si sono appropriati della battaglia per il free speech, ammantando l’espressione di un significato sinistro: lo sdoganamento dei discorsi d’odio. Ma sotto questa patina si cela la necessità di una scelta di campo che riguarda anche (anzi: anzitutto) la sinistra: come ha scritto in un ispirato editoriale l’Observer, il tentato omicidio di Salman Rushdie dev’essere un campanello dall’allarme per quei progressisti che da anni accolgono con una scrollata di spalle l’erosione del diritto alla libera espressione di idee differenti o controverse, un fenomeno che la veemenza omologante delle infosfere socialmediali ha reso di stretta attualità.
Oltre le strumentalizzazioni conservatrici di quest’epoca, la libertà di espressione – come ha notato, fra gli altri, il columnist di Jacobin Ben Burgis – dovrebbe rimanere «un valore non negoziabile della sinistra». A noi pare più che altro un concetto astratto, a cui riservare nel migliore dei casi un’adesione tiepida e sbadigliante, da formulario. Eppure il suo vero valore si manifesta proprio nella possibilità di causare un’offesa in buona fede, di andare contro l’ortodossia dominante in un dato contesto: nessuno stato totalitario, nessun tentato assassinio politico d’altronde ha mai cercato di censurare idee con cui concordava, o che non gli facevano né caldo né freddo. È ovvio che non tutte le intolleranze per le opinioni dissonanti generano violenza, ma tutte limitano e immiseriscono l’esperienza umana e lo spirito stesso del progresso.
C’è differenza tra l’offesa malevola fine a se stessa e il pensiero libero che risulta oltraggioso, e la distinzione non è affatto di lana caprina: è ciò che divide l’apertura democratica al dissenso dalla chiusura assolutistica, tanto per cominciare. È lo stesso Rushdie ad avercelo insegnato: ha scritto che «il momento in cui stabilisci che un set di idee deve essere immune dalla critica, la satira, la derisione e anche il disdegno, la libertà di pensiero diventa impossibile». E ancora, in Patrie immaginarie (Mondadori, 1994):
Che cos’è la libertà di espressione? Senza la libertà di offendere, cessa di esistere. Senza la libertà di sfidare, o anche di dileggiare ogni ortodossia, comprese quelle religiose, cessa di esistere. Il linguaggio e l’immaginazione non possono essere imprigionati o l’arte morirà, e con essa, un po’ di ciò che ci rende umani.
Lo scrittore non si è limitato agli alti proclami, peraltro: nel 1990, a un anno dalla fatwa, un film pakistano lo dipinse come un agente di Satana al soldo di ebrei e induisti che distrugge l’Islam, da uccidere con l’ausilio di copie del Corano volanti. Il Regno Unito non voleva permetterne la distribuzione, ma Rushdie si mosse in prima persona perché potesse essere visto dal pubblico. Il free speech, di per sé, sarebbe questa cosa qua, e non possiamo sminuirne la portata perché qualche cattivo dei cartoni animati si è messo ad abusare del termine.
È comprensibile che oggi le strumentalizzazioni politiche carpiate sorte attorno alla «libertà di espressione» inducano a guardare il concetto con una certa diffidenza. Ma la storia di Rushdie ci mostra il mondo al di fuori della caverna algoritmica, ed è su questo squarcio di verità e importanza che dovremmo concentrarci; è lì che viviamo, d’altronde.
Già al tempo della sua condanna a morte – contornata da una taglia di 3 milioni di dollari e ribadita dalla massima autorità religiosa e civile iraniana non più tardi che nel 2019 – molti non riuscirono a solidarizzare con Rushdie: l’ex presidente americano Jimmy Carter scrisse apertamente sul New York Times che il suo romanzo era «un insulto». Una lunghissima lista di progressisti pose l’accento sulle persone che si sentivano offese dalla sua opera, solidarizzando con loro e non con lui. Diciotto anni dopo, quando il governo britannico decise di conferirgli la massima onorificenza pubblica del cavalierato, la ministra dell’Istruzione libdem Shirley Williams prese posizione in prima serata televisiva contro un uomo che aveva «offeso milioni di musulmani».
Da allora la situazione non è migliorata, anzi: quando nel 2015, a pochi mesi dalla strage islamista nella redazione parigina di Charlie Hebdo, il Pen America decise di conferire un riconoscimento postumo alle vittime degli attentatori, più di 200 scrittori suoi membri (e tra gli altri Teju Cole, Joyce Carol Oates, Geoff Dyer) scrissero per lamentarsi della decisione di premiare «materiale selettivamente offensivo». Nella lettera si leggeva che «in una società diseguale, l’offesa eguale non ha un effetto eguale», un argomento che oggi vediamo comparire abitualmente nelle prese di posizione progressiste che equiparano l’espressione personale e artistica a sorgenti di discriminazione o violenza materiale.
Ponendo che l’equazione regga, quale potrebbe essere la soluzione al dilemma se non una «offesa diseguale», cioè un’arte (o una libera espressione) libera di occuparsi soltanto di certi gruppi e di certe idee? Ma uno scenario del genere costituirebbe l’antitesi stessa dell’apertura democratica, e di ciò per cui la sinistra ha sempre combattuto nella sua storia, fin dall’Illuminismo. Cosa pesa di più, dunque: l’offesa o la libertà di offendere? Salman Rushdie, parlando alla Columbia University nel 1991, si è chiesto: «Quale minoranza è più piccola e più debole di quella di una singola persona?». Due anni fa lo scrittore è stato tra i firmatari della discussa lettera della rivista Harper’s sulla cosiddetta cancel culture (un’iniziativa che, anche allora, larghe nicchie di sinistra hanno liquidato come un piagnisteo di celebrità milionarie incapaci di tollerare le critiche), e da trent’anni è un testimonial vivente e coerente della libertà di espressione di tutti e per tutti.
Il grande Christopher Hitchens scrisse nelle sue memorie che la fatwa di Rushdie metteva di fronte «tutto ciò che amavo e tutto ciò che odiavo»: da una parte «dittatura, religione, stupidità, demagogia, censura, bullismo e intimidazione»; dall’altra «letteratura, ironia, humor, l’individuo e la libertà di espressione». Per quanto non sia sempre così semplice tracciare la linea, anche a noi prima o poi toccherà scegliere da che parte stare.
Altre news dal fronte
- Il teatro londinese Shakespeare's Globe ha fatto impazzire Twitter (ehi, un attimo: l’ho scritto davvero?) presentando I, Joan, uno spettacolo in cartellone dalla fine di questo mese che immagina Giovanna d’Arco come una persona non binaria che usa i pronomi they/them. Un giorno qualche antropologo studierà la frenesia generale causata nell’etere da cose del genere, in sé innocue, ma comunque: a quanto ho appreso, i critici (stando al fronte avversario su Twitter, al 99,9% Terf: ma sono uno di quelli ancora convinti che il mondo non si possa dividere con un tratto netto in «Terf» e «alleati») obiettano che Giovanna d’Arco è una delle relativamente poche donne “protagoniste” e che trascendono gli stereotipi di genere ad aver lasciato un segno sulla storia occidentale, e toglierle la sua appartenenza sessuale si tradurrebbe in un disservizio alla causa femminista. Altri, invece, pongono l’accento sulla possibilità di re-immaginare la storia alla luce delle sensibilità odierne, una parte integrante della produzione artistica contemporanea, e dunque sulla legittimità del progetto;

- Storia ai limiti del paranormale e molto discussa segnalatami da Stefano M., che ringrazio: quest’anno sul Journal of Qualitative Research, una rivista accademica peer-reviewed, è apparso un paper di un ricercatore svedese all’Università di Manchester, Karl Andersson, che – non so davvero come altro dirlo – per tre mesi si è masturbato su fumetti shota, un particolare sottogenere di anime che rappresenta scene di sesso con ragazzini prepubescenti, e ha descritto e ammantato l’opinabile routine con la dicitura di «studio etnografico».
Lo scoppio della vicenda, dopo mesi di tranquilla pubblicazione online, risale soltanto a qualche giorno fa, e nel mentre il paper è stato rimosso (la norma vuole che vengano ritirati pur rimanendo online, leggevo, e questo aveva già una nota editoriale a corredo. Ma non divaghiamo). Andersson si occupa di shota in modo estensivo: ci ha girato un documentario, ha un passato da direttore ed editore di un riprovevole e non legalissimo giornale dedicato alla pornografia infantile e insomma, non facciamo torto a nessuno nel dire che è un pedofilo conclamato.
A interessarci è anzitutto un aspetto messo in luce dal divulgatore scientifico scozzese Stuart Ritchie, che ha dedicato un articolo di commento alla lunare faccenda: la storia è esplosa grazie a un tweet di un politico britannico conservatore, il parlamentare Tory Neil O’Brien, che l’ha portata alla ribalta il 10 agosto scorso. E siccome a indignarsi era stato un tizio di destra, mostra Ritchie, diversi accademici di chiara fama sono intervenuti per... difendere il paper di riflesso. Qui di seguito ad esempio trovi la presa di posizione della storica della cultura esperta di questioni legate al sesso Fern Riddell:

E qui quella di Steven Fielding, professore di storia politica all’Università di Nottingham:

Ma Ritchie ne elenca diverse altre (alcuni degli autori, a onor di completezza, poi si sono scusati per la colpevole svista). Come una cosa del genere possa essere stata pubblicata su una rivista peer-reviewed esula dalle mie competenze specifiche (nonché dalla mia considerazione delle università del 2022), ma è deprimente vedere anche come spesso le faide su Twitter ormai prescindano completamente dal merito delle questioni, ovvero dalla realtà stessa: basta seguire la corrente e, con un po’ di buona volontà e tic pavloviani, si finisce a fare le guerre culturali al fianco di dottorandi che fanno, uhm, “ricerca scientifica” masturbandosi sui ragazzini.
(aggiungi l’indirizzo ai tuoi contatti, altrimenti rischi che la newsletter finisca nella cartella Spam)